Deepwater Horizon
La marea nera che disturba i sogni di Obama

Il riscaldamento globale che sta sconvolgendo il clima del nostro pianeta è un processo inesorabile che avviene in maniera sempre più veloce negli ultimi anni. Nonostante le preoccupazioni frequenti degli ambientalisti, l’aumento della temperatura terrestre non ha incontrato alcun limite sia per l’incapacità degli Stati di porre un freno all’inquinamento, sia per l’assoluta onnipotenza delle mutlinazionali del greggio. E ciò che è successo a Copenaghen a dicembre scorso sta lì a dimostrarlo.
Oltretutto, nonostante le promesse degli ultimi anni, il passaggio dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili, a ciò che negli Stati Uniti del Presidente Obama era stata ribattezzata la “green economy”, od a ciò che Jeremy Rifkin definisce la “terza rivoluzione industriale”, viene costantemente rimandato. Ponendo gravi rischi per il futuro dell’umanità, ma anche per l’immediato presente: basti osservare la lunga serie di incidenti che hanno visto protagoniste le multinazionali del settore.
Lo scandaloso comportamento della British Petroleum durante l’incidente della piattaforma petrolifera a largo della Luisiana, in pieno Golfo del Messico, dimostra due cose: la prima è che il danno ambientale provocato dall’utilizzo delle fonti fossili non va circoscritto solo all’inquinamento da utilizzo, ma spesso ricomprende anche incidenti più o meno gravi, di cui ormai è costellata la storia mondiale, e che hanno ripercussioni inimmaginabili sugli ecosistemi per gli anni (o per i decenni) a venire; la seconda è che proprio in tali occasioni si dimostra l’onnipotenza delle multinazionali petrolifere nei confronti degli Stati sovrani. In questo caso una sola compagnia pertrolifera, ossia la BP, è riuscita a tenere in ostaggio nientemeno che il Governo degli Stati Uniti.
L’incuria per la rapida progressione degli eventi che hanno scatenato l’ultimo grave danno all’ambiente ha dell’eclatante: il 20 aprile scorso un’esplosione improvvisa ha colpito la Deepwater Horizon, una piattaforma petrolifera della compagnia Transocean, a 50 km dalle coste della Louisiana. Il contratto per le perforazioni è della British Petroleum.
La piattaforma, divenuta operativa nel 2001, operava ad una profondità di 1.700 metri. L’incidente ha causato inizialmente grande apprensione per la sorte dei 127 operai presenti sulla piattaforma: 17 di loro sono stati gravemente feriti dall’esplosione, mentre i dispersi sono stati 11. Alla tragedia che ha colpito i lavoratori, si sono però immediatamente aggiunte le preoccupazioni ambientali dell’incidente. La perdita di petrolio, derivante da due buchi che hanno interessato la trivella a cinquemila metri di profondità, si è rivelata inarrestabile, anche se la multinazionale petrolifera ha cercato subito di rassicurare gli animi. I mille barili di greggio al giorno, stimati da fonti interne alla BP, che sgorgavano sulla superficie del mare, erano una quantità ingente che minacciava per il momento solo l’area interessata, anche se la macchia si allargava sempre di più.
Dai vertici della BP si continuava però a negare il disastro ecologico, fiduciosi nelle tecnologie messe a disposizione dal progresso. Solo che le leggi della natura si sono rivelate più forti di qualsiasi robot sottomarino, di qualsiasi cupola creata per arginare la perdita ( o meglio, per raccogliere l’oro nero che rischiava di andare disperso e vanificato, bruciando i profitti di uno dei settori più remunerativi dell’epoca della globalizzazione).
Quando si è realizzata la gravità della situazione, era ormai troppo tardi. La scoperta di una terza falla e la conseguente revisione della stima di fuoriuscita del greggio ha fatto sembrare l’incidente della Exxon Valdez nel 1989 una bazzecola: non più mille barili al giorno, ma cinquemila, con la BP che contestava la stima, cercando di minimizzare, per non dover pagare più di tanto i danni provocati. E la marea nera, come è stata ribattezzata dalla stampa internazionale la fuoriuscita di petrolio, che inondava il fragile ecosistema delle coste della Louisiana, inghiottendo tutto ciò che incontrava.
Il diritto internazionale, grazie ad una serie di pronunce della Corte Internazionale di Giustizia, è riuscito ad affermare il principio, ormai consuetudinario, della responsabilità dei danni ambientali causati dalle multinazionali agli Stati. Il concetto, ormai facente parte del diritto internazionale generale è “chi inquina paga”, e gli Stati Uniti faranno valere le loro ragioni mettendo la British Petroleum con la spalle al muro per l’incidente della Deepwater Horizon.
Anche per questo la Casa Bianca non ha preso il comando delle operazioni, al fine di lasciare alla BP il compito di riparare ai danni causati e presentare il conto alla fine. E qui si entra nel discorso più propriamente politico. Se tale ragionamento andava bene nel caso in cui il danno si fosse rivelato contenuto e limitato, il Presidente Obama avrebbe avuto tutto le ragioni per lasciare alla BP il difficile ruolo di capro espiatorio e mostrarla al pubblico ludibrio.
Ma il fatto che mentre scriviamo la falla non è stata tamponata, e l’intero Golfo del Messico rischia l’ecatombe ecologica, porterà in calce, oltre alla firma della BP, accusata di negligenza, incapacità di reazione, ma soprattutto di aver mentito sulle stime del disastro, anche la firma di Barack Obama, incapace di gestire una catastrofe che ha sporcato uno dei punti più importanti del programma presidenziale: l’avvio della famosa “green economy”. La marea nera ha inghiottito anche quel sogno.
Per approfondire, consigliamo le tesi:
Il caso Exxon Valdez e il danno ambientale: valutazione economica, prevenzione e rimedi di Cristiano Balderi Magnin
Globalizzazione e salvaguardia dell'ambiente di Francesco Delfino
Umberto Profazio
Institute for Global Studies
[Nell'immagine: La fuoriuscita di petrolio al largo della Louisiana è uno dei peggiori disastri ambientali degli ultimi anni]
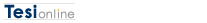
 Iscriviti alla Newsletter Geografia!
Iscriviti alla Newsletter Geografia!
La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype