Lo stallo del processo di pace e gli accordi di Camp David

Dopo la morte di Rabin, fu nominato primo ministro Shimon Peres, anche lui artefice degli accordi di Oslo, e il processo di pace proseguì anche se a rilento, ostacolato soprattutto dalla ripresa di attacchi terroristici contro la popolazione israeliana.
Il 3 e il 4 marzo 1996, kamikaze palestinesi organizzarono due bombardamenti suicidi in cui morirono 32 cittadini israeliani. Questi due attentati causarono la caduta politica di Peres. Come risposta, infatti, gli israeliani elessero come primo ministro (per la prima volta in maniera diretta) Benjamin Netanyahu, leader del partito conservatore Likud.
Gli anni di Netanyahu furono caratterizzati da un atteggiamento ostile nei confronti dell'ANP di Arafat, che portò inevitabilmente ad uno stallo nel processo di pace. Dopo 4 anni però, lo stesso Netanyahu (in seguito anche ad una serie di scandali interni) perse credibilità sia nei confronti del popolo israeliano che della comunità internazionale.
Nelle consultazioni del 1999, infatti, Ehud Barak, a capo del partito laburista, fu eletto primo ministro. Una delle prime iniziative di Barak (il militare più decorato della storia d'Israele), fu il ritiro delle forze militari dalla zona di sicurezza del Libano meridionale, dando così un nuovo impulso al difficoltoso processo di pace.
Tra il'11 e il 14 luglio 2000, Barak e il leader dell'ANP, Arafat, si incontrarono negli Stati Uniti a Camp David, ospitati dal presidente USA, Bill Clinton. Senza introdurre nuove clausole, le due parti si impegnarono a ripartire dalle risoluzioni 242 e 338 dell'ONU e a evitare azioni unilaterali che potessero inficiare l'esito dei negoziati.
A Camp David, però, il processo di pace si arrestò improvvisamente, quando Arafat abbandonò il tavolo delle trattative. Il motivo fu la richiesta da parte dell'ANP del ritiro di Israele dai Territori Occupati e il ritorno ai confini del '67 (e non quelli del '73) come precondizione per il proseguimento dei negoziati, nonostante le concessioni dello stato ebraico fossero le più "generose" mai offerte alla Palestina (il 91% della striscia di Gaza e della Cisgiordania, il controllo palestinese su Gerusalemme Est e un fondo monetario per l'indennizzo e il rientro dei profughi palestinesi, che all'epoca erano circa 700.000).
Dal canto suo Israele chiedeva di poter installare avamposti militari in territorio palestinese, controllarne lo spazio aereo, dispiegare truppe in caso d'emergenza, lo stazionamento di una forza internazionale nella valle del Giordano e, più di ogni cosa, la demilitarizzazione della Palestina. Nonostante gli sforzi diplomatici, dal 2000, il conflitto israelo-palestinese non si è placato, anzi, si è andato radicalizzando sempre più. In particolar modo, dall'isolamento di politico di Arafat (confinato nel suo quartier generale a Ramallah dalle truppe israeliane guidate da Sharon), alla sua morte, in Francia, l'11 Novembre 2004.
L'atteggiamento del leader dell'ANP, giudicato ambiguo da buona parte dei mediatori internazionali e dallo stato ebraico, portarono ad un nuovo stallo del processo di pace. Nel frattempo che Hamas, organizzazione politico-militare palestinese di stampo radicale e islamica, molto probabilmente finanziata dall'Iran, guadagnava sempre più consenso, soprattutto nella striscia di Gaza. Dal 2006, infatti, l'ANP perse il totale controllo della striscia, diventata ormai la roccaforte di Hamas che il 25 gennaio 2006 vinse le elezioni legislative.
L'ennesima invasione israeliana del Libano meridionale (causata dall'uccisione da parte di Hezbollah di soldati israeliani) e i bombardamenti di Gaza a cavallo tra il 2008 e il 2009, hanno portato ad un empasse nella risoluzione del conflitto.
[Nell'immagine: Barak, Clinton e Arafat a Camp David nel 2000]
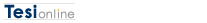
 Iscriviti alla Newsletter Geografia!
Iscriviti alla Newsletter Geografia!
La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype