L’attacco alla Nazionale del Togo e gli indipendentisti in Cabinda

L’8 gennaio 2010 l’autobus che trasportava la nazionale di calcio del Togo in Angola è stato vittima di un attentato che ha causato la morte di tre persone.
L’attentato è stato rivendicato dalla Forza di liberazione dello Stato della Cabinda Posizione Militare (FLEC-MP), ma anche dalle Forze Armate della Cabinda (FLEC-FAC). Entrambi i gruppi ribelli hanno comunque precisato che l’attacco era diretto contro le truppe angolane di scorta, e non contro la nazionale del Togo, che in seguito all’attentato si è ritirata dalla Coppa d’Africa 2010, svoltasi in Angola e che prevedeva alcune partite proprio in Cabinda.
La notizia ha fatto subito il giro del mondo, non tanto per la sua gravità, quanto per la presenza di alcune personalità famose rimaste coinvolte nell’attentato. Si è fatto subito il nome di Emmanuel Adebayor, stella della Premier League e del Manchester City, coinvolto nell’attentato insieme ad altri giocatori che militano nei migliori club europei. I loro piedi valgono miliardi di euro, tanti quanti ne spera di ricavare la FIFA dai prossimi Mondiali che si terranno quest’anno in Sudafrica.
Il tragico evento dell’8 gennaio ha messo in allarme i Paesi occidentali sulla situazione che potrebbero trovare quest’estate nel continente dimenticato. Ed ha acceso i riflettori su uno dei conflitti più antichi dell’Africa. La Cabinda è un’exclave angolana che confina con il Congo-Brazzaville e la Repubblica Democratica del Congo. La creazione dell’exclave della Cabinda è eredità del colonialismo europeo, in quanto sia l’Angola che la Cabinda furono unificate sotto l’Impero del Portogallo. Tuttavia, alla fine del regime di Salazar, in seguito alla rivoluzione dei garofani del 1974, tutte le colonie portoghesi proclamarono l’indipendenza, compresa la Cabinda.
L’Angola riuscì a prendere il controllo della Cabinda, ma fu subito preda della guerra civile che vide contrapporsi l’Unione per l’indipendenza totale dell’Angola (UNITA) al Movimento Popolare di Liberazione dell’Angola (MPLA). La situazione di caos all’interno dell’Angola facilitò l’intervento delle potenze occidentali: il periodo della guerra fredda non era ancora finito e la lotta tra Stati Uniti ed Unione Sovietica proprio in quegli anni conobbe il suo massimo dispiegamento sul territorio africano.
In Angola l’intervento dei “volontari” cubani e degli aiuti sovietici fu concentrato sulle forze del MPLA, mentre gli americani ed i sudafricani puntarono le loro fiches sull’UNITA. Approfittando della guerra civile la Cabinda organizzò immediatamente un proprio movimento indipendentista per sottrarsi dal controllo del debole regime di Luanda, facendo leva su ragioni storiche, territoriali ed etnografiche. Con la fine della guerra fredda anche il conflitto in Angola ha perso la sua ragion d’essere.
La morte del leader dell’UNITA, Jonas Savimbi, ha riappacificato il Paese ed ha consentito inoltre al regime di Josè Eduardo Dos Santos, leader del MPLA, al potere da 30 anni, di dispiegare in Cabinda circa 30.000 soldati per reprimere i movimenti separatisti. Ma gli indipendentisti non hanno mai smesso di rivendicare l’indipendenza per il proprio territorio, ed hanno intensificato la loro lotta contro il potere centrale.

Il presidente dell'Angola,
Josè Eduardo Dos Santos
Secondo i dati di Jeune Afrique l’Angola è divenuto nel 2009 il primo produttore di petrolio del continente africano e Luanda produce il 60% dei propri idrocarburi proprio in Cabinda. In questa sottile striscia di terra sono presenti alcune delle più importanti multinazionali del settore (comprese la francese Total, l’americana Chevron e l’italiana Eni). Che ruolo giocano nella battaglia indipendentista queste multinazionali? Per loro è più facile trattare con il governo di Luanda o sarebbe meglio sedersi al tavolo delle trattative con un ministato appena indipendente?
Comunque stiano le cose è certo che la battaglia degli indipendentisti è portata avanti per riequilibrare i proventi delle vendite petrolifere, oggi a tutto vantaggio del regime di Dos Santos. E tale situazione non è dissimile da quella del Darfur, in cui viene contrastato il governo centrale del Sudan per non dissimili ragioni. Anche in questo caso, quindi, la mano dell’Occidente, della globalizzazione e dei potentati economici ha lanciato la pietra e non ha fatto nulla per nascondere la mano.
Per approfondire, consigliamo le tesi:
La comunità internazionale e il conflitto angolano durante la guerra fredda di Evelina Crespi
La ristrutturazione geopolitica dell'Africa centrale di Matteo Calabresi
Umberto Profazio
Institute for Global Studies

[Nell'immagine: Una delle imagini che ritraggono il calciatore Adebayor durante gli scontri in Angola]
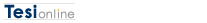
 Iscriviti alla Newsletter Geografia!
Iscriviti alla Newsletter Geografia!
La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype