Il conflitto israelo-palestinese
L'origine di un conflitto che da mezzo secolo insanguina il Medio Oriente, con ripercussioni enormi in tutto il mondo

Dopo la nascita dello stato di Israele, le nazioni arabe confinanti appoggiarono la popolazione palestinese, invadendo a più riprese lo stato ebraico. Col passare degli anni, anche i palestinesi si organizzarono in un movimento politico e militare, di grande peso furono l'OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina, nata nel 1964) e Al-Fatah, spina dorsale della lotta armata palestinese, fondato nel 1959 da Arafat.
La nazionalizzazione del canale, però, ebbe ripercussioni a livello internazionale ben più gravi: Gran Bretagna e Francia, che dalla fine del diciannovesimo secolo (cioè dalla caduta dell'Impero Ottomano), nonostante l'indipendenza dell'Egitto, avevano un forte controllo sugli scambi commerciali nello stretto, furono costrette a lasciare la regione.
Israele, quindi si rivelò essere un ottimo alleato: tre mesi dopo, infatti, lo stato ebraico invase la Striscia di Gaza e la penisola del Sinai avanzando verso il canale, mentre le nazioni europee iniziarono a bombardare l'Egitto, costringendolo a riaprire lo stretto.
La crisi nel canale di Suez ebbe ripercussioni internazionali ancora più grandi, nel momento in cui si inserì nelle tensioni tra il blocco comunista, che si schierò a favore dell'Egitto, e gli Stati Uniti in un primo momento schierati accanto alle nazioni europee.
Per l'inizio del 1957 tutte le truppe israeliane si erano ritirate dal Sinai. Il timore di un'improvvisa escalation delle operazioni militari, infatti, spinse gli USA a frenare l'avanzata bellica di Regno Unito e Francia.
Intanto, il ministro degli esteri canadese, Lester Pearson (vincitore per il Nobel per la pace, grazie alla sua mediazione nella crisi), ottenne l'invio di una forza militare di interposizione sotto l'egida dell'ONU (la prima dalla sua nascita), con lo scopo di "mantenere i confini in pace mentre si cercava un accordo politico".
Da un punto di vista politico, la crisi di Suez rappresentò punto nodale nella costruzione di un'asse USA-Israele, facendo degli Stati Uniti il più stretto alleato dello stato ebraico, riducendo in maniera drastica il ruolo delle nazioni europee, che all'epoca del colonialismo avevano esercitato un'enorme influenza nell'area.
La questione di Gerusalemme – Gerusalemme fu proclamata capitale d'Israele nel 1950 e confermata come tale, nel 1980, con "legge fondamentale" promulgata dalla Knesset, il parlamento israeliano.
Entrambe le proclamazioni non sono mai state riconosciute come valide dalla comunità internazionale, tanto che una serie di Risoluzioni dell'ONU considerano parte dell’insediamento israeliano nella città come Territorio Occupato. Per questo motivo, tutte le ambasciate straniere risiedono a Tel Aviv.
Gerusalemme Est fu conquistata durante la guerra dei sei giorni, e de facto è amministrata da Israele, sebbene continua ad essere rivendicata dai palestinesi, come capitale del proprio stato. E proprio la zona orientale (cioè la parte vecchia) è luogo di culto per le tre maggiori religioni monoteistiche. Alcuni esempi:
la spianata del Tempio o delle Moschee (sacro per gli ebrei in quanto sede del Tempio di JHWH, per i musulmani, invece, è sacro perché il profeta Maometto venne assunto in cielo dalla roccia situata in cima al monte, oggi all'interno della Cupola della Roccia);
il Muro occidentale (conosciuto anche come il Muro del Pianto, cioè il muro di cinta del primo Tempio di Gerusalemme, sacro per l’ebraismo);
la Chiesa del Santo Sepolcro, dove, secondo la tradizione cristiana, fu crocifisso Gesù.
Entrambe le proclamazioni non sono mai state riconosciute come valide dalla comunità internazionale, tanto che una serie di Risoluzioni dell'ONU considerano parte dell’insediamento israeliano nella città come Territorio Occupato. Per questo motivo, tutte le ambasciate straniere risiedono a Tel Aviv.
Gerusalemme Est fu conquistata durante la guerra dei sei giorni, e de facto è amministrata da Israele, sebbene continua ad essere rivendicata dai palestinesi, come capitale del proprio stato. E proprio la zona orientale (cioè la parte vecchia) è luogo di culto per le tre maggiori religioni monoteistiche. Alcuni esempi:
la spianata del Tempio o delle Moschee (sacro per gli ebrei in quanto sede del Tempio di JHWH, per i musulmani, invece, è sacro perché il profeta Maometto venne assunto in cielo dalla roccia situata in cima al monte, oggi all'interno della Cupola della Roccia);
il Muro occidentale (conosciuto anche come il Muro del Pianto, cioè il muro di cinta del primo Tempio di Gerusalemme, sacro per l’ebraismo);
la Chiesa del Santo Sepolcro, dove, secondo la tradizione cristiana, fu crocifisso Gesù.
Intanto, secondo le informazioni ottenute dal Mossad, i servizi segreti israeliani, Egitto, Siria e Giordania stavano ammassando truppe a ridosso dei propri confini. Pertanto nel 1967 Israele decise di passare ad un attacco preventivo.
Sotto il comando dei generali Yitzhak Rabin (Capo di Stato Maggiore) e Moshe Dayan (Ministro della Difesa), in soli sei giorni, a partire dal 5 giugno 1967, Israele sconfisse gli eserciti dei tre paesi arabi, conquistando la Cisgiordania e Gerusalemme Est (che erano sotto l'amministrazione giordana), la Penisola del Sinai, le Alture del Golan, la Striscia di Gaza, allargando in maniera sensibile i propri confini originari.
Nei Territori Occupati durante la guerra dei sei giorni, Israele rifiutò di applicare la Quarta Convenzione di Ginevra, cioè negando ai palestinesi dei Territori gli stessi diritti politici dei cittadini israeliani, né dei benefici accordati dalle leggi di Israele.
L'ONU intervenne con una risoluzione, la 242, che imponeva ad Israele il ritiro dai territori e alle nazioni arabe il riconoscimento dello stato ebraico. Ma, il netto rifiuto da parte arabe di riconoscere Israele, portò quest'ultima a rimanere nei Territori.
In risposta, il 17 ottobre 1973 i membri dell'Organizzazione dei paesi arabi esportatori di petrolio (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, OAPEC) decisero di non esportare più l'oro nero nei paesi sostenitori dello stato di Israele (in particolare Stati Uniti e Olanda per aver fornito armi ai sionisti), innescando così la crisi petrolifera del 1973.
La guerra dello Yom Kippur ridisegnò per l'ennesima volta i confini dello Stato di Israele che riuscì ad annettere tutta la città di Gerusalemme, buona parte della striscia di Gaza (fino ad allora controllata dall'Egitto) e la penisola del Sinai (controllata dalla Giordania), costringendo ad un nuovo intervento da parte delle Nazioni Unite.
Con la Risoluzione 338, l'ONU invitava Israele a ritirarsi dai Territori Occupati in funzione di un possibile avvio di trattative di pace, nonché alla cessazione delle attività terroristiche dei palestinesi. Anche se riluttante, Israele accettò le condizioni, e altrettanto fecero Nasser e re Husayn di Giordania, ma Siria e palestinesi rifiutarono.
Pare che parte del rifiuto da parte araba fosse dovuto da una certa ambiguità all'interno del condizioni imposte dalle Nazioni Unite: la risoluzione non indicava con precisione da quali Territori, se da tutti o da una parte, si sarebbe dovuto ritirare lo stato ebraico. I Territori Occupati durante la guerra dei sei giorni sono ancora tutt'ora oggetto di disputa. A partire dagli anni '70, infatti, nella striscia di Gaza e in Cisgiordania si diressero molti israeliani, creando colonie agricole e insediamenti, talvolta abusivi, costringendo le popolazioni arabe alla fuga.

Il presidente egiziano Sadat
nominato persona dell'anno
1978 dal settimanale
americano, Time
Una visita storica che gli valse il Nobel per la pace nel 1978 e che portò agli accordi di Camp David, in cui Israele si impegnava a ritirarsi dalla penisola del Sinai, in cambio l'Egitto riconosceva lo Stato ebraico.
Nel 1981, Sadat fu ucciso da estremisti islamici, gettando l'ennesima ombra lunga sul processo di pace. E le tensioni con i paesi confinanti non si placarono. Nel 1978 Israele invase il sud del Libano (accusato di appoggiare l'OLP e le altre organizzazioni terroristiche palestinesi), costringendo l'ONU a creare una zona cuscinetto tra i due paesi, sorvegliata dai "caschi blu".
Nelle operazioni in Libano si consumò il massacro dei campi profughi di Beirut, Sabra e Shatila, per mano delle forze falanghiste libanesi, con una forte responsabilità da parte dell'esercito israeliano e del Ministro della Difesa di allora, Ariel Sharon, costretto a dimettersi e farsi da parte nella politica israeliana per 20 anni.
A partire dal 1987, nei Territori Occupati si alzò un moto popolare che cercava di combattere la presenza israeliana. L'Intifada (in arabo "brivido, scossa"), attraverso scioperi, disobbedienza civile e il lancio di pietre contro i tank israeliani cercò di attirare l'attenzione dei media e della comunità internazionale sulla complicata situazione medio orientale.
I gruppi estremistici di matrice islamica che non si riconoscevano nell'OLP (per sua stessa natura laica e di ispirazione socialista) diedero vita ad un movimento radicale chiamato Hamas (nato a Gaza proprio nel 1987) che esacerbò lo scontro con le forze militari israeliane con un crescendo di attentati terroristici suicidi.
Nello stesso periodo, le posizioni dell'OLP andarono ammorbidendosi sempre più, cercando di abbandonare la lotta terroristica e aprendosi alla diplomazia, tanto che nei primi anni '90, si giunse al primo (e forse il più significativo) processo di pace tra Israele e OLP.
[Nell'immagine: I protagonisti della guerra dei sei giorni: a destra il generale Narkiss, al centro il ministro della difesa Dayan e a destra Rabin, all'epoca Capo di Stato Maggiore]
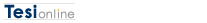
 Iscriviti alla Newsletter Geografia!
Iscriviti alla Newsletter Geografia!
La redazione è online su Skype dalle 9 alle 13.
Contatta la nostra redazione a: [email protected] o via Skype